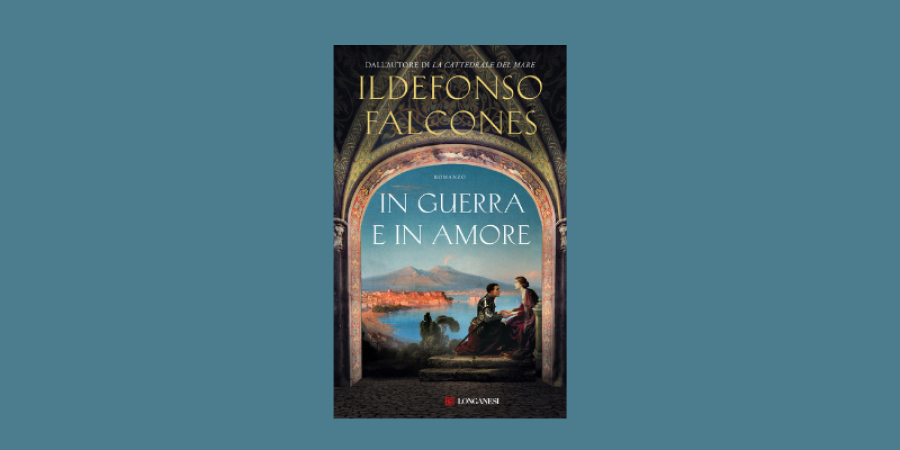Intelligenza Artificiale e lettura: consigli personalizzati o fine del libraio?
Non è un mistero che l’intelligenza artificiale (AI) stia entrando a passo sempre deciso anche nel mondo del libro. Dagli algoritmi dei principali siti per acquistare libri online alle app di suggerimenti automatici, la tecnologia promette di rivoluzionare il modo in cui scegliamo cosa leggere. Ma questa innovazione rappresenta davvero un passo avanti per i lettori? O rischia di oscurare la figura centrale del libraio, custode di storie e interprete delle esigenze di chi legge?
L’AI che suggerisce libri: come funzionano gli algoritmi
Le piattaforme digitali utilizzano sempre di più sofisticati algoritmi per analizzare gusti, acquisti e comportamenti degli utenti. Amazon, per esempio, è pioniera nel campo: i suoi consigli di lettura automatici si basano infatti su una mole immensa di dati. Anche app come Goodreads (sempre di proprietà Amazon) o StoryGraph propongono letture simili a quelle già apprezzate, sulla base di valutazioni sui generi preferiti e sulle abitudini di lettura di ognuno di noi. Queste tecnologie offrono consigli di lettura automatici, frutto dell’intelligenza artificiale applicata al consumo culturale. L'obiettivo è fidelizzare il lettore, facilitare la scoperta di nuovi titoli e aumentare le vendite.
I limiti degli algoritmi nella scoperta di nuovi libri
Tuttavia, per quanto evoluta, l’AI non è infallibile. I consigli possono risultare ripetitivi, basati esclusivamente sulla “comfort zone” del lettore. I suggerimenti rischiano di rinforzare abitudini già esistenti, anziché stimolare esplorazioni nuove, con il risultato di un generale appiattimento sui propri gusti. Gli algoritmi infatti non comprendono per davvero né il libro né il lettore: mancano dell’intuizione, dell’empatia, della capacità di cogliere sfumature. Non possono quindi intercettare la voglia di leggere qualcosa di diverso, di imprevisto.
Un altro aspetto critico è la scarsa trasparenza: su cosa si basano gli algoritmi? Si tratta sempre di dati di preferenza, o intervengono anche logiche commerciali e promozionali? Al momento non è dato saperlo.
Il valore della competenza umana: il libraio resta insostituibile
Al contrario, il libraio non lavora per analogie matematiche, ma stabilisce relazioni umane. Ogni libraio conosce i suoi lettori, ne interpreta gusti, stati d’animo, interessi. È in grado di dire: “Fidati: è questo il libro giusto per te”. A differenza degli algoritmi, il consiglio di un libraio non è mai impersonale: è calibrato sulla persona e può essere un momento decisivo per la formazione dei lettori, soprattutto di chi si sta avviando alla lettura. Le AI possono classificare, ma non possono sorprendere né creare legami con le persone.
In molte librerie Ubik per esempio la scelta delle vetrine, dei titoli in evidenza, degli allestimenti speciali, sono frutto della passione dei librai e della conoscenza del proprio pubblico. Dietro ogni scelta non c’è un algoritmo, ma una proposta pensata per la propria comunità di lettori sul territorio.
AI e librai: sfida o alleanza?
Quanto detto finora non significa che la professione del libraio debba essere forza in contrasto con l’AI. Anzi, se ben integrata, la tecnologia può diventare uno strumento utile. Ci sono vari ambiti del lavoro del libraio in cui l’AI può tornare utile, per esempio:
- per semplificare la gestione dell’assortimento.
- per raccogliere dati sulle preferenze dei lettori e migliorare l’offerta della libreria.
- per curare newsletter personalizzate.
Ma è fondamentale che sia il libraio a guidare la tecnologia, e non viceversa. Solo così l’innovazione può davvero arricchire l’esperienza di lettura, senza sostituire il valore umano.
L'AI come opportunità, non come sostituto
L’intelligenza artificiale nel mondo dei libri è una realtà crescente, con vantaggi e rischi. I consigli dettati dagli algoritmi sono utili, ma non devono diventare l’unico orizzonte del lettore. Il futuro delle librerie – e del piacere di leggere – passa da un equilibrio tra innovazione tecnologica e competenza umana. Finché ci saranno librai capaci di ascoltare e consigliare con passione, l’intelligenza artificiale resterà un supporto, non una minaccia.